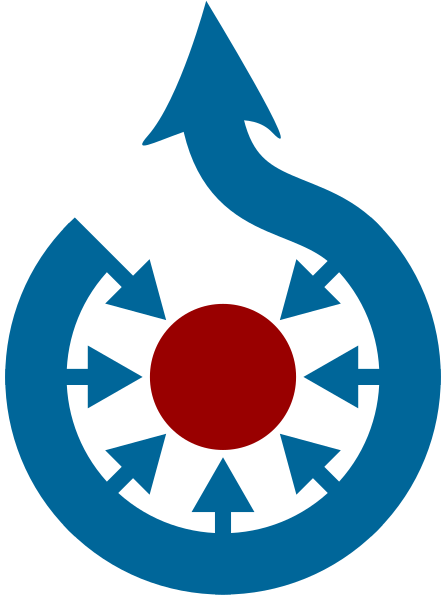Fino a pochi anni fa parlare di “comune” e di “beni comuni” sembrava quasi un intellettualismo, una concettualizzazione ancora ben relegata nel campo teorico.
E' sorprendente come nell'arco di un brevissimo arco temporale quei concetti abbiano trasmigrato, siano usciti dal campo della teoria e siano entrati nella quotidianità di tutti con una potenza di diffusione ed una capacità di concretizzazione impareggiabili. Una diffusione così ampia e veloce che ha anche destato la preoccupazione che quell'idea potesse essere inflazionata o prestarsi ad un uso strumentale che ne avrebbe snaturato il contenuto. Non sono mancati neppure i tentativi di “rimettere un po' di ordine nelle cose” cercando di elaborare una definizione più stringente e dettagliata del concetto di beni comuni, ma il più delle volte tali definizioni sono state oltrepassate dall'effettivo utilizzo sociale di quel concetto. Certo, di utilizzi strumentali ne abbiamo visti e ne vedremo ancora in futuro.
Tuttavia alla base del rapido diffondersi di quell'idea dentro la crisi, della sua capacità di catalizzare aspirazioni e rivendicazioni, del suo emergere in contesti del tutto improbabili, c'è un qualcosa di profondamente autentico, un bisogno radicale e radicato che impedisce di “chiudere” il concetto di beni comuni, di dargli una catalogazione statica che sia valida una volta per tutte. Ancora una volta è il vissuto sociale di un'idea e la realtà materiale che essa di fatto interpreta che ne determina il contenuto ed il contenuto che si è andato sedimentando intorno al concetto di beni comuni è un qualcosa che travalica il bene in quanto tale, che lo oltrepassa per cogliere, in maniera diretta o indiretta, il contesto sociale all'interno del quale il bene è inserito. Ciò che rende un bene “comune” non sono le sue caratteristiche e neppure il suo legame con le essenziali necessità del genere umano, legame che, semmai, può servire unicamente ad individuare nella più ampia categoria dei beni comuni un nucleo di beni vitali per il ruolo diretto che tali beni svolgono ai fini della stessa sopravvivenza fisica.
Ciò che rende un bene “comune” sono in realtà i rapporti di produzione e le relazioni sociali che sussumono il bene ad una finalità e ad una logica altra rispetto a quella dominante. In sostanza è il “comune”, ovvero l'intreccio delle relazioni sociali e produttive che lo caratterizzano a rendere un bene comune e non viceversa. Ed è per questa stessa ragione che il lavoro, per come lo conosciamo, non può essere definito bene comune: esso esprime l'essenza del rapporto di produzione e di sfruttamento capitalistico. Il lavoro può essere un diritto prodotto dalla coercizione di un contesto in cui non esiste altra possibilità di accedere al reddito se non quella di sottoporsi al rapporto di sfruttamento lavorativo: in ogni caso un concetto ben diverso da quello di bene comune. I beni collocati al di fuori delle relazioni sociali e produttive non sono né comuni né privati né pubblici: semplicemente esistono e si sottraggono persino alla definizione di “bene” che è pur sempre una definizione umana, sostanzialmente giuridica, di qualcosa che esiste a prescindere da qualsivoglia definizione.
E', dunque, la relazione sociale, intesa nel suo significato più ampio, a determinare la funzione e quindi l'appartenenza ad una data categoria di un bene: uno spazio occupato diventa bene comune per le attività che vi vengono svolte e, quindi, per le diverse relazioni sociali e produttive che si instaurano al suo interno. Ed è sempre la relazione sociale che immette il bene nel mondo del diritto, ovvero in un mondo che è interamente di produzione umana. Ci sono alcuni beni, come ad esempio l'aria o l'acqua, che per il loro diretto ed immediato rapporto con la nostra sopravvivenza fisica vengono universalmente percepiti come non “appropriabili”, non “privatizzabili” e quindi come beni “naturalmente” comuni. Tale percezione, tuttavia, può rivelarsi fuorviante. In realtà per le esigenze di sopravvivenza fisica del genere umano l'aria e l'acqua non sarebbero beni più “naturalmente comuni” della terra che produce gli alimenti necessari per la nostra vita e che, ciononostante, è stata così da tanto tempo ridotta a privata proprietà da averne persino rovesciato la percezione sociale, consolidando la convinzione contraria, ovvero che sia “naturale” che un pezzo di terra abbia un proprietario.
E' proprio la storia del capitalismo, l'impareggiabile violenza della sua appropriazione, la sua pervicace intromissione e manipolazione dei codici genetici ad insegnarci che i beni, di qualsiasi natura essi siano, sono beni “di tutti” solo fintantochè qualcuno non se ne appropria così come la storia dei movimenti ci insegna che, al contrario, un bene è privato fintantochè i movimenti non lo restituiscono alla sua funzione sociale. I beni comuni, dunque, non sono un qualcosa di già dato, l'omaggio di una sorta di “diritto naturale” che travalica la realtà umana, ma il risultato di un conflitto costante e sempre più profondo che contrappone il comune, come insieme di relazioni sociali e rapporti di produzione, ai quotidiani dispositivi di appropriazione delle ricchezze da parte del capitale.
I conflitti non difendono i beni comuni, li costituiscono: al di fuori di tale osmosi conflittuale la categoria dei beni comuni perde di senso perchè non c'è nulla che in sé non sia appropriabile e non esiste alcun confine “naturale” ai dispositivi di appropriazione del capitale. Anche quando parliamo di beni comuni in riferimento a contesti che attualmente appartengono alla sfera del “pubblico”, come ad esempio la sanità e l'istruzione, in realtà ci riferiamo non al bene in quanto tale ma sempre al bene inserito in determinate relazioni sociali e produttive. E' sicuramente un fatto positivo, quindi un “bene” che esista un sanità, ovvero un sistema organizzato preposto alla cura ed all'assistenza delle persone malate. Ma quando noi parliamo di sanità come bene comune intendiamo un'altra cosa, ci riferiamo ad una sanità preposta alla cura ed all'assistenza delle persone che sia gratuita ed accessibile a tutti, le cui prestazioni siano sottratte alle regole del mercato ed allo sfruttamento della condizione di malattia: in sostanza parliamo di relazioni, rapporti di produzione e rapporti di mercato. Il fatto che la sanità pubblica garantisca, seppur parzialmente, alcune di tali caratteristiche è esclusivamente il frutto di un conflitto: ciò che di bene comune troviamo nella sanità pubblica esiste esclusivamente in quanto relazioni non ridotte al mero scambio di mercato e, per questo, in perenne conflitto con le tensioni privatizzatrici.
Se, dunque, ciò che rende un bene “comune” sono primariamente le relazioni sociali e produttive all'interno delle quali esso è inserito o che ne sono la condizione stessa della sua produzione, i beni comuni non solo non possono configurare una categoria chiusa ma non possono neppure configurare una categoria esterna all'attività che li determina: i beni comuni si costituiscono all'interno dei conflitti che il comune genera ogni qual volta riesce ad affermare, seppur in forma frammentaria ed embrionale, relazioni sociali e rapporti di produzione “altri”. Questo significa che quando parliamo di beni comuni in realtà non parliamo di un “oggetto” ma di un “soggetto” e non parliamo di un'attività costituente potenziale ma di un'attività costituente già in atto.
Dire che i beni comuni non sono semplicemente un “oggetto” ma sono essenzialmente un “soggetto” significa dire che ciò che rende un bene comune non sono le sue caratteristiche statiche, la sua collocazione nel mondo delle “cose” ma, al contrario, la sua dimensione dinamica, ovvero l'agire, il fare, dentro cui quel bene è collocato. Questo significa che quando ci poniamo il problema del rapporto tra beni comuni e diritto non poniamo semplicemente il problema della condizione giuridica di un oggetto, ma il problema estremamente più complesso della condizione giuridica di un agire che rivendica agibilità all'interno di un ordinamento pur originandosi dalla legittima sottrazione o violazione dalle/delle sue regole. Una reinterpretazione di alcuni precetti costituzionali così come qualche buona legge, possono certamente aiutare a risolvere alcune problematiche specifiche, ma non potranno mai risolvere l'insanabile contrasto che contrappone il comunecome insieme di pratiche sociali riappropriative e redistributive e l'ordinamento dato, che non è semplicemente un insieme di norme ma, al contrario, una dimensione sistemicapreordinata ad un fine a cui il comune per sua natura non è riducibile se non attraverso la propria negazione.
Che tipo di rapporto è, dunque, possibile tra beni comuni e diritto? O meglio, esiste la possibilità di una relazione che si sottragga alla duplice e deleteria tentazione di eludere il problema attraverso la semplificazione ideologica che da un lato costruisce l'illusoria fiducia nell'azione risolutrice in una legge amica e sul versante opposto l'altrettanto illusoria prospettiva di un processo costituente che si mantiene del tutto separato dall'ordinamento costituito sino al suo conclusivo rovesciamento? Per potersi interrogare intorno a tale rapporto è innanzitutto necessario chiarire che cosa intendiamo per diritto. Generalmente si tende a sovrapporre il significato di diritto con quello di “diritto positivo” che nel linguaggio giuridico indica il diritto vigente ovvero l'insieme delle leggi e dei regolamenti che il potere costituito impone come normazione della vita sociale. Il fatto che la legge nella percezione sociale abbia occupato l'intero campo semantico del diritto non è un caso ma il frutto di una possente operazione ideologica che ha attraversato tutta la modernità sin dalle sue origini. Espansione del “diritto positivo” e modernità sono termini inscindibili, condivisione genetica di un processo di vastissime proporzioni che porta all'affermazione plurisecolare del capitalismo e del suo specifico ordinamento giuridico.
Un “diritto delle leggi” che evolve con la modernità stessa e che con la stessa condivide le trasformazioni, i sussulti, le contraddizioni e, soprattutto, la sua “doppiezza”, l'essere nel contempo strumento di emancipazione dalle pregresse “mitologie” del potere e dalle sue origini metafisiche e strumento di subordinazione al potere tutto umano dell'economia e del mercato, il decretare nel contempo la fine della servitù e l'inizio della “libera” vendita di se stessi al padrone di turno, affermare l'uguaglianza di tutti i cittadini difronte alla legge frantumando la favola del “sangue blu” e restituendo ad esso il colore rosso comune a tutti gli esseri umani, per poi farne dimostrazione facendolo scorrere nei massacri perpetrati ai danni dei lavoratori in sciopero o nelle guerre per la conquista di nuovi mercati. Emancipazione ed oppressione, la doppia faccia del diritto che si afferma nella modernità, la doppiezza necessaria alla funzione che esso assolve all'interno del processo rivoluzionario e costituente attraverso il quale si afferma e “costituisce” il capitalismo nella sua dimensione economica, politica ed, inevitabilmente, giuridica. Lo sviluppo del capitalismo e le trasformazioni attraverso le quali è stato capace di interfacciare la conflittualità sociale, sarebbero impensabili, quantomeno nelle forme che abbiamo conosciuto, senza la congenita espansione del “diritto positivo” e la sempre più estesa legificazione della società e delle sue relazioni. Eppure, al di là di tutto, resta il fatto di per sé emancipatorio di un processo che poteva aver luogo solo a condizione che la problematica del diritto diventasse una questione tutta ed esclusivamente umana, calata nei rapporti di produzione, sottratta ai dimensionamenti trascendentali ed ai condizionamenti di una Chiesa sempre violentemente determinata ad affermare il proprio ruolo di custode ed interprete terreno di una presunta “legge naturale” promulgata direttamente da Dio attraverso l'esistente.
Ma la portata potenzialmente liberatoria di un diritto interamente calato nella realtà umana non poteva che condurre con sé una contraddizione di fondo, perchè se nella fase costituente del nuovo ordine capitalistico esso assolveva alla fondamentale funzione di rovesciamento degli assetti di potere pre-esistenti, nella fase del capitalismo come ordine costituito rischiava di trasformarsi in un enorme pericolo potendo essere fonte di rivendicazione e legittimazione di assetti giuridici altri e contrapposti a quello dominante. E' all'interno di questo quadrante che, attraverso una molteplicità di percorsi e di strumenti teorici, ideologici, economici e giuridici, si determina la progressiva riduzione del diritto alla legge, ovvero l'esclusione e l'eliminazione sistematica di qualsiasi assetto giuridico diverso dall'ordinamento costituito, la marginalizzazione di qualsiasi fonte del diritto che non fosse la legge stessa ed i processi di legificazione previsti dall'ordinamento. Non è un caso che la massima espansione del “diritto delle leggi” si sia verificata proprio con l'affermarsi delle democrazie liberali all'interno delle quali l'assolutismo giuridico, e quindi l'occupazione di ogni spazio giuridico da parte della legge, trova la sua giustificazione nell'affermazione ideologica della legge come espressione della volontà popolare e della sua osservanza come condizione di esercizio della democrazia. Un' equazione ideologica che ha consentito di “legificare” ogni ambito della nostra vita, individuale ed associata, di astrarre l'idea stessa di legalità dal concreto contenuto delle leggi, facendone un valore assoluto ed un parametro etico completamente dissociato dalla giustezza o meno degli obiettivi perseguiti dalle singole norme. Un processo di colonizzazione da parte della legge di ogni dimensione giuridica, che ha progressivamente chiuso ogni spazio di autonormazione, ogni possibilità di legittimazione di ordinamenti giuridici altri, la cui autonomia è condizione necessaria al perseguimento di finalità che non coincidono con quelle dell'ordinamento costituito.
Muovere da queste brevi premesse può essere utile per chiarire quale significato attribuiamo sotto il profilo giuridico al concetto di “processo costituente”. Il “diritto costituente” è in primo luogo quella dimensione del diritto che recupera la propria spinta liberatoria e trasformatrice emancipandosi dalla legge, ovvero dalla codificazione del suo assoggettamento all'ordine costituito. Diritto e legge non sono affatto sinonimi e la sovrapposizione del concetto di diritto con quello di “diritto positivo” è, in realtà, un inganno. Dentro i gangli della cooperazione sociale, ogni volta che si verifica una sottrazione ai dispositivi predisposti di valorizzazione, si produce un evento giuridico a sua volta produttivo di “diritto” seppur non nella forma codificata della legge. Le dimensioni autogestionarie che “vigono” all'interno di centinaia di spazi occupati in realtà sono già ordinamenti giuridici “altri”: il fatto che la loro estensione applicativa sia contenuta dentro i confini fisici di un luogo non ne modifica la natura. Un ordinamento giuridico non è semplicemente un insieme di norme, formalizzate o non formalizzate che siano: l'ordinamento giuridico è un “sistema”, una dimensione organizzativa che esprime una regolamentazione orientata al raggiungimento di determinati fini. Un “discorso costituente” implica sul piano giuridico la messa in discussione della legge come unica dimensione del diritto e la rivendicazione della pluralità degli ordinamenti giuridici che la dimensione del “comune” produce: ordinamenti che costituiscono nella materialità la sfera giuridica del comune ed in assenza dei quali la categoria dei “beni comuni” null'altro sarebbe se non un modo diverso di definire un'articolazione del “pubblico”, magari a tutela rafforzata.
Tornando, dunque, all'interrogativo iniziale circa il tipo di rapporto possibile tra beni comuni e diritto, dovremmo innanzitutto premettere che i beni comuni sono già espressione di una dimensione del diritto e che, quindi, il problema in realtà attiene al tipo di rapporto possibile tra questa dimensione del diritto e la legge, ovvero tra il diritto costituente ed il diritto costituito. Quando diciamo che è necessario affermare l'esistenza di una sfera giuridica “terza” rispetto a quella pubblica ed a quella privata in realtà a che cosa alludiamo? Che cosa significa imporre all'interno dell'ordinamento costituito il “riconoscimento” dei beni comuni come dimensione dinamica, come espressione di un agire della cooperazione sociale fondativo di un”altro” diritto, di una dimensione giuridica sottratta al disciplinamento della legge? Si tratta di una questione complessa che può facilmente generare la tentazione di semplificare il tutto riducendo tale “riconoscimento” alla conquista di un nucleo di buone leggi che detti una disciplina garantista sulla gestione dei beni comuni e sulle relative tutele, magari integrata con alcune forme di partecipazione da parte della cittadinanza attiva.
In realtà, però, tale prospettiva non risolve affatto il problema di fondo. Certamente alcune importanti modifiche agli attuali assetti normativi potrebbero essere utili ed utilizzabili. La legislazione vigente ed i suoi campi di applicazione non possono non essere un terreno costante di osservazione e di intervento, tantopiù in una fase come quella attuale dove la caduta vertiginosa dei diritti e delle garanzie produce effetti devastanti sulla vita di milioni di persone ed innalza altrettanto vertiginosamente i livelli di repressione della conflittualità sociale. E neppure deve essere sottovalutata la portata propulsiva di innovazioni normative che possono allargare gli spazi di azione ed ostacolare i processi di privatizzazione. Tuttavia il tema dei beni comuni ci pone difronte ad un quid pluris, alla necessità di misurarci con un qualcosa che va oltre un'importante campagna sui diritti sociali e civili: ci dà la possibilità e l'occasione di misurarci direttamente con la dimensione costituente del comune dalla quale il tema dei beni comuni non può essere separato perchè essi non possono che costituirsi dentro le relazioni sociali e produttive che il comune, direttamente o indirettamente, sviluppa.
Tale dimensione costituente del comune produce ed è espressione di una dimensione giuridica che necessariamente si manifesta all'interno dell'ordinamento giuridico costituito come “antinomia”, che nel linguaggio giuridico indica la compresenza di norme incompatibili e che nel significato etimologico configura un “anti-nomos”, un qualcosa di contrapposto alla legge. Se rivendicare il “riconoscimento” dei beni comuni all'interno dell'ordinamento giuridico costituito ha come obiettivo l'affermazione della nuova sfera giuridica del comune, l'oggetto di tale riconoscimento non può consistere nella risoluzione dell'antinomia, nella sua eliminazione attraverso la legificazione, e quindi il disciplinamento, dell'”agire” che sta alla base del bene comune. L'oggetto di tale “riconoscimento” non può che essere l'antinomia in quanto tale, l'accettazione della sua esistenza in quanto variante non riassorbibile, in ultima analisi l'accettazione di uno stato di eccezione che trae origine, questa volta, dai movimenti sociali.
Nel linguaggio giuridico si parla di poteri extra ordinem per indicare facoltà straordinarie che la legge attribuisce agli organi dello Stato per fronteggiare situazioni eccezionali. La caratteristica peculiare dei poteri extra ordinem sta nel fatto che nonostante tali poteri comportino una violazione delle garanzie costituzionali o di altre leggi fondamentali, il loro esercizio viene comunque legittimato e reso forzosamente compatibile attraverso l'eccezionalità della situazione che deve essere fronteggiata: in sostanza è lo stato d'eccezione che rende possibile l'esistenza dell'antinomia. Ma se lo stato d'eccezione rende possibile l'esistenza di un'antinomia sul versante del potere, lo stesso stato d'eccezione può costituire il fondamento legittimante di un'antinomia che si produce sul versante dei movimenti. In questo caso lo stato d'eccezione è dato dalla crisi, dall'impoverimento generalizzato, dalla privatizzazione e dalla sottrazione delle risorse fondamentali alla vita. Ilcomune nella sua dimensione costituente produce un evento giuridico extra ordinem che si impone all'interno dell'ordinamento in quanto stato d'eccezione e che, tuttavia, permane al suo interno come antinomia, ovvero come dimensione giuridica autonoma seppur “riconosciuta”.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare non si tratta di un ragionamento eminentemente teorico, ma di un approccio che ha profonde implicazioni pratiche. Se rapportiamo tale ragionamento al bene comune rappresentato dagli innumerevoli spazi occupati ed autogestiti che popolano i nostri territori diventa forse più facile focalizzarne la portata concreta. Individuare gli strumenti giuridici attraverso cui legittimare un'occupazione è già estremamente difficile: il fatto che occupare integri un'illegalità non è la conseguenza di una “cattiva” legge, ma il frutto fisiologico di un complessivo assetto normativo proprietaristico. Immaginare che una legge possa in via ordinaria e generale, astraendosi dal caso concreto, riconoscere la legittimità delle occupazioni è del tutto illusorio: è certamente più credibile immaginare la possibilità di un atto normativo che, in presenza di determinate condizioni, e quindi nel contesto di un'eccezione che si pone al di fuori della dimensione ordinaria (ad esempio l'emergenza casa), sancisca la non perseguibilità dell'occupazione sotto il profilo penalistico e la sua legittimazione sotto il profilo civilistico. Tuttavia la questione dell'assegnazione di uno spazio occupato rappresenta solamente una parte del problema. Anche quando, magari attraverso percorsi vertenziali, si riesce a conseguire l'assegnazione di uno spazio occupato, i problemi non sono affatto finiti, perchè la reazione da parte dell'ordinamento giuridico dominante, che opera in quanto sistema e non come semplice sommatoria di norme, si sposta immediatamente dallo spazio fisico in quanto tale all'”agire” che si determina al suo interno e che trasforma quello spazio in bene comune. Così una volta risolto il problema dell'assegnazione ci ritroviamo immediatamente a fare i conti con una pluralità di dispositivi normativi che attengono alla fiscalità, alle normative di sicurezza, alle normative sanitarie, alle licenze ed alle autorizzazioni, che attaccano l'agire comune con il duplice obiettivo o di normalizzarlo o di mantenerlo nell'illegalità, con la conseguente possibilità di azionare all'occorrenza i relativi strumenti repressivi. Quello che spesso si verifica nell'esperienza pratica è, dunque, che nonostante l'assegnazione dello spazio il mantenimento dell'agire comune passa attraverso la costante violazione di norme e la sua tutela continua sostanzialmente a fondarsi sui rapporti di forza e sulle prospettive di resistenza.
In via ordinaria non esiste una soluzione a questo problema: non potrà mai esistere una legge che riconosca come dimensione ordinaria dell'ordinamento il diritto ad occupare uno spazio ed a gestirlo al di fuori delle molteplici normative vigenti. La soluzione deve necessariamente essere “extra-ordinaria”, il che, di per sé, non preclude il “riconoscimento” dell'evento giuridico extra ordinem, anzi lo rende possibile in quanto evento che esprime uno stato d'eccezione. Tornando al tema degli spazi occupati ed autogestiti in questa prospettiva l'oggetto del “riconoscimento” non è limitato al riconoscimento del diritto al mantenimento dello spazio (o al conseguimento di uno spazio alternativo) ma alla legittimità stessa della sua gestione extra ordinem, ovvero secondo meccanismi di auto-normazione che individuano al proprio interno la soluzione delle problematiche attinenti alla gestione economica, alla sicurezza ed alle tutele sanitarie. Ma cosa significa rivendicare il riconoscimento di un evento giuridico extra ordinem, ovvero il riconoscimento all'interno di un ordinamento giuridico dominante di un'antinomia?
Significa sostanzialmente rivendicare il riconoscimento di una “zona franca”, di “luoghi” rispetto ai quali, in ragione dello stato di eccezione che ne legittima l'esistenza, la legge riconosce il proprio confine. Stiamo parlando di una dinamica politica e giuridica che nel corso della storia si è verificata più volte in presenza di profonde trasformazioni economiche, sociali, politiche e, quindi, anche giuridiche. D'altra parte, il concetto di “zona franca” non è affatto nuovo e lo stesso capitale vi ha fatto ripetutamente ricorso quando, per qualche ragione, vi ha trovato una convenienza sotto il profilo economico e fiscale: talvolta le zone franche sono state utilizzate proprio per ridare slancio economico a zone particolarmente depresse. E' possibile costruire una nostra declinazione di “zona franca” che vada oltre l'aspetto economico per investire un più ampio dimensionamento delle relazioni sociali e produttive? Si è scritto molto sulla crisi e sul suo utilizzo come legittimazione da parte del potere di uno stato d'eccezione permanente. Ma allo stato d'eccezione alimentato dai poteri finanziari, economici e politici come è possibile reagire se non attraverso un'eccezione contrapposta che rifugga dalla tentazione, peraltro del tutto irrealistica, di pensare che l'eccezionalità possa essere riportata nell'ordinarietà pre-esistente, strappandoci così di mano, con la paura, l'azzardo del cambiamento? Nel contesto di una crisi di vastissime proporzioni e delle urgenze che essa determina, una concreta prospettiva sperimentabile può essere costituita dalla rivendicazione di “zone franche” come dimensione immediatamente costituente del comune e del suo agire, come ordinamento giuridico “altro” e motore economico di una diversa economia, all'interno della quale anche la tematica del reddito di cittadinanza tende ad oltrepassare la dimensione debole della relazione diretta “Stato-cittadino” per interporvi un diaframma collettivo. Di fronte all'attuale livello di legificazione sociale e di normazione delle nostre vite, è difficile immaginare un nuovo protagonismo conflittuale che non ponga da subito, direttamente o indirettamente, il problema non solo della violazione della legge ma anche della sua ritrazione dai luoghi che il conflitto produce. I primi tentativi di occupazione dei luoghi di lavoro e di avvio di produzioni autonome come potrebbero sopravvivere se non costituendosi e rivendicandosi come “zona franca”?
Negli ultimi tempi il nostro Paese è stato teatro di un costante ricorso ai poteri extra ordinem, nell'ambito del quale il presidente Napolitano si è contraddistinto per pervicacia e fantasiosità dell'interpretazione. Ma il problema in un simile contesto non è tanto gridare al “colpo di stato” ed al ripristino della legalità, quanto, piuttosto, capire quali sono i poteriextra ordinem che rivendichiamo a noi stessi, che possono essere agiti ed imposti dai movimenti. E', in sostanza, il tema dell'illegalità che oggi si ripropone con forme e contenuti nuovi, che oltrepassa la rottura della norma costituita per assumere la problematica del fondamento costituente, del consolidamento delle antinomie come prodotto del comune, come dimensione giuridica autonoma che, seppur non ancora dotata di un accumulo di potenza tale da affermarsi come dimensione generale, può da subito cimentarsi con la propria affermazione come eccezione, come antinomia all'interno dell'ordinamento giuridico dominante.
Il percorso avviato dalla costituente dei beni comuni può essere un'importante occasione per sviluppare una riflessione collettiva che affronti il nodo del rapporto tra legge ed autonomia delle dimensioni giuridiche che si producono nella sfera del comune, tra il diritto come esercizio del potere costituito ed il diritto come processo costituente in atto. Una relazione certamente complessa che non può essere risolta con un tecnicismo giuridico e neppure con il semplice richiamo a qualche precetto costituzionale d'avanguardia perchè il problema dell'antinomia, nell'accezione sopra utilizzata, non è un problema “tecnico” ma un problema tutto sociale e politico, rispetto al quale le conoscenze tecniche possono fornire strumenti utili nel contesto degli obiettivi e delle strategie che maturano nell'agire sociale e nelle sue dimensioni conflittuali. Proprio per questo motivo è importante che la costituente dei beni comuni resti il più possibile una dimensione aperta che, nell'assumere lo spessore di un ragionamento realmente costituente, scelga di misurarsi con il tema dei beni comuni come dimensione di un agire e di un essere delle relazioni sociali, e, quindi, come dimensione che aspira alla sua “zona franca” piuttosto che al suo disciplinamento attraverso la legge. Questo, ovviamente, non significa che importanti modifiche normative non possano essere utili o che alcune leggi non possano essere meglio di altre o che attraverso una legge non possano essere costruite alcune garanzie che oggi non ci sono. Tutto ciò, però, difficilmente potrà andare oltre una “qualificazione” della sfera del “pubblico” e la sua integrazione con alcuni dispositivi partecipativi. A tale riguardo va sottolineato che tale qualificazione potrebbe avere, a sua volta, una funzione propulsiva e che per alcuni beni comuni la sfera del pubblico continuerà ad essere per non poco tempo il “luogo migliore” (nel senso del meno peggio) in cui preservarli in attesa della maturazione di una sfera del comune adeguata alla complessità della loro gestione.
Ciononostante se parliamo di processi costituenti ci poniamo una prospettiva ulteriore ed in questa ulteriore prospettiva è possibile dare corpo a concrete sperimentazioni che pongano la tematica giuridica al di fuori dei confini della legge, restituendola interamente al sociale e facendone il volano di un principio organizzativo della cooperazione sociale che si costituisce come dimensione del comune e, quindi, come zona tendenzialmente “affrancata” dalla legge. Tali sperimentazioni sono concretamente possibili perchè già esistono come evento giuridico autonomo (spazi e teatri occupati, case occupate, mercatini non autorizzati, produzioni autonome, comitati nati su problematiche di quartiere, forme di mutualità ecc...) e perchè nella condizione di crisi è fisiologico che tendano a diffondersi, portando con sé la contraddizione, solo apparente, tra il desiderio di voler uscire dalla precarietà dell'illegalità e la necessità di essere illegali per poter sopravvivere: contraddizione solo apparente che in realtà esprime l'esigenza di affermazione di un'altra dimensione del diritto, ovvero il riconoscimento dell'antinomia e del connesso diritto della zona franca ad esistere. Fare della costituente dei beni comuni un luogo dove è possibile misurarsi anche con questo orizzonte ci impone di disancorare, almeno in parte, il ragionamento da una prospettiva meramente “codicistica”. Da questo punto di vista non è molto comprensibile la sovrapposizione che non di rado si è verificata tra costituente dei beni comuni e “Commissione Rodotà”.
La Commissione Rodotà venne istituita nel 2007 dal ministro Mastella con il compito di elaborare per il governo uno schema di disegno di legge avente ad oggetto la riforma, orientata al “recupero della funzione ordinante del diritto della proprietà e dei beni”, di alcune parti del codice civile attinenti alla materia dei beni pubblici. Senza dubbio i giuristi chiamati a comporre la Commissione colsero l'occasione per un ragionamento di più ampia portata nell'ambito del quale il tema dei beni comuni assumeva un'inedita cittadinanza. Ciononostante la Commissione in quanto tale aveva obiettivi contenuti all'interno del mandato conferitole ed era parte di un contesto storico e politico, quello del governo Prodi e della relativa legislatura, lontano anni luce dal nostro presente, precedente persino all'esplosione della grande crisi. Rievocare la Commissione oggi rischia di confondere gli orizzonti del ragionamento e non se ne comprende bene l'utilità. D'altra parte anche il contributo più strettamente tecnico che i giuristi possono dare alla costituente dei beni comuni andrebbe aperto, reso reticolare, costruendo una sinergia tra i molti operatori del diritto sensibili alle questioni sollevate dalla costituente. Come già si è verificato in altri campi, ad esempio nell'ambito del diritto dell'immigrazione, la costante ed aperta relazione tra coloro che a vario titolo hanno specifiche conoscenze tecnico-giuridiche, potrebbe costituire un valido e permanente strumento di consultazione ed elaborazione, idoneo anche a far fronte ad esigenze specifiche e ad essere un utile strumento di “garantismo attivo”. Anche da questo punto di vista non si comprende bene per quale ragione la geografia dei giuristi dovrebbe essere ricalcata su quella della vecchia Commissione Rodotà, con l'inserimento di qualche cooptazione decisa dallo stesso gruppo di giuristi, e non essere, invece, aperta e liberamente accessibile. Questa impostazione rischia di creare dinamiche di personalizzazione che sono sempre riduttive e che possono rovesciare il corretto rapporto tra i movimenti ed i suoi strumenti. Resta comunque il fatto che il diffuso interesse suscitato dalla costituente dei beni comuni è un importante indicatore delle molteplici istanze che vivono nei territori e delle loro necessità di trovare un costrutto comune. Per questo motivo è importante valorizzare il percorso avviato ed arricchirlo con la riflessione collettiva affinchè la costituente dei beni comuni possa crescere ed essere, essa stessa, sempre di più zona franca, luogo di confronto ed interazione di un “pensare comune”.